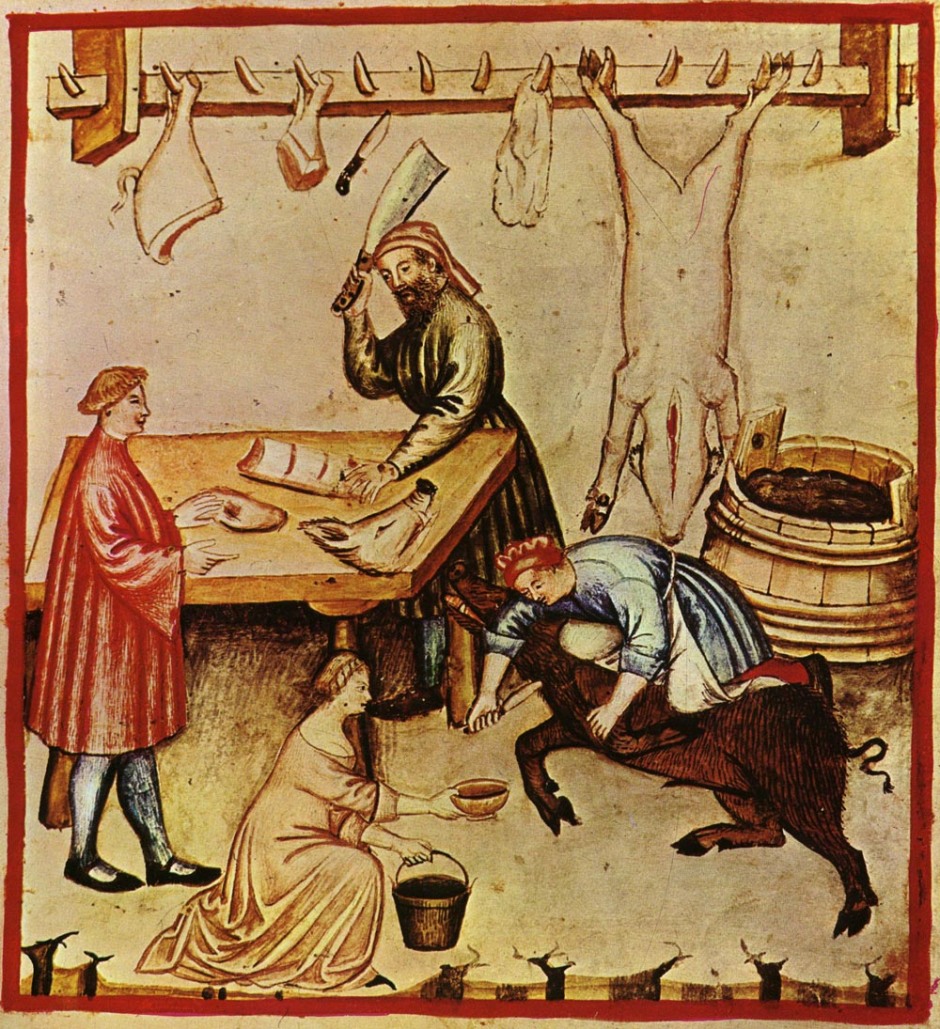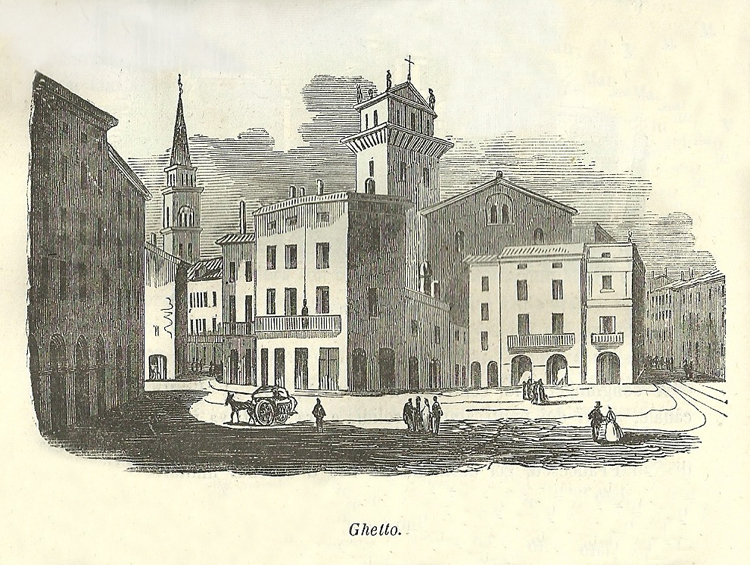Nel Palazzo Ducale è facile sentirsi contemporaneamente dentro e fuori, al chiuso e all’aperto, vedere una sala affrescata e uno spazio governato dalla vegetazione. Muovendosi tra Corte Vecchia e Corte Nuova è possibile compiere un itinerario che riscopre la vita da cortile, tra nomi sognanti e spazi che non sempre si ha la curiosità di vedere. Quando si cammina all’interno del Palazzo occorre essere curiosi e guardare fuori dalla finestra, per fingere di orientarsi e per comprendere che ogni ritaglio di linee è uno spazio.
La Galleria degli Specchi si affaccia sul Cortile dei quattro platani detto anche giardino dei bossi. Presente già con Isabella d’Este, viene utilizzato da Guglielmo Gonzaga per festeggiare il matrimonio con Eleonora d’Austria. Dalla finestra del Gabinetto dei Mori, guardando in basso, si vede il Cortile a Otto Facce o degli Orsi. Realizzato da Bernardino Facciotto, il cortile ha la forma di un ottagono allungato ed era completamente affrescato e presentava bassorilievi in stucco di trionfi d’armi. Venne chiamato “degli orsi” nel 1908 da Achille Patricolo forse perché nel Settecento veniva usato per gli spettacolo circensi con gli animali. Al di sotto c’è una piccola terrazza. Sotto il cortile c’è la ghiacciaia mentre sopra, a 12 metri, il giardino pensile. Verso Piazza Santa Barbara si trova un piccolo spazio triangolare noto come Cortile del Frambus forse una forma dialettale del nome francese del lampone, framboise. Il Cortile di Santa Croce si trova invece nell’area dell’appartamento vedovile di Isabella d’Este dove si trovava la chiesa di Santa Croce. La facciata, rivolta verso l’interno del cortile è ancora in parte visibile e denota uno sviluppo verticale. Fu voluta dal marchese Gianfrancesco Gonzaga negli anni venti del Quattrocento con funzione di cappella palatina.
In Corte Nuova la piccola loggia, compresa tra il camerino dei falconi e quello degli uccelli, si apre sul Cortile dei Cani detto anche dei Giarelli. Nato probabilmente come piccola terrazza pensile aperta verso il lago, diventa poi cortile con Guglielmo e “cimitero” dei cani tra cui la lapide della cagnolina Oriana, opera di Giulio Romano. Attraversata piazza Castello ed entrati nella fortezza di San Giorgio si rimane incantati all’interno di un cortile che esalta l’architettura toscana, realizzato infatti dalla coppia Fancelli-Mantegna. Affrescato e porticato su tre lati, il cortile viene trasformato nel Settecento.
Bibliografia: Stefano L’Occaso, Palazzo Ducale Mantova, Electa 2011
Immagine: Studio Calzolari 1950-65, Cortile dei quattro platani (fonte Lombardia Beni culturali)