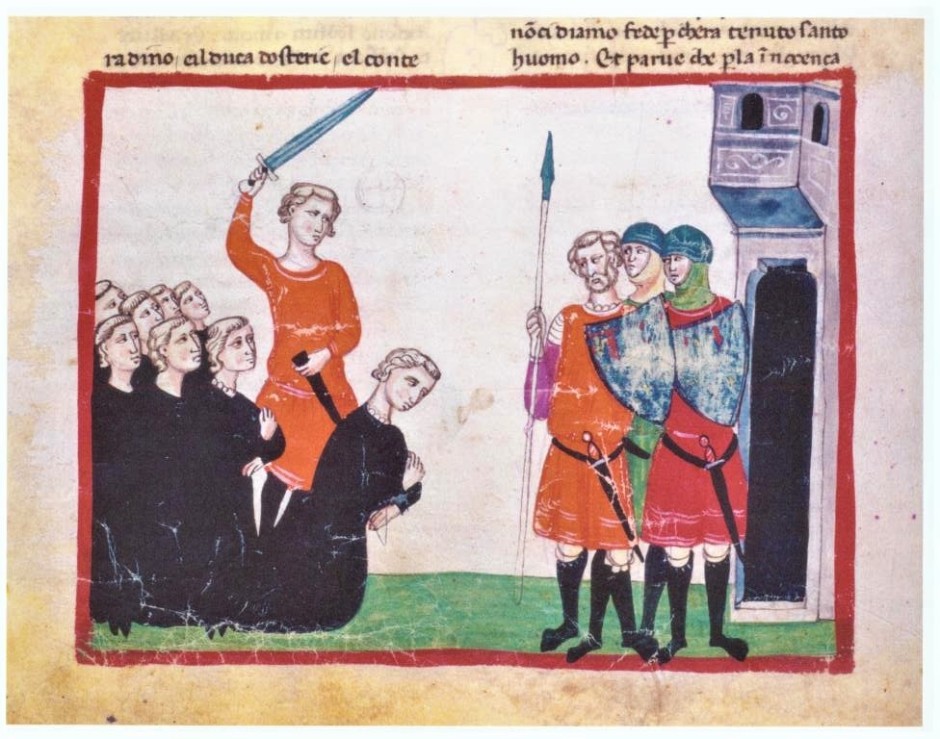Il contesto lombardo e milanese nel Quattrocento vede la presenza di giocatori di scacchi unita ad una forte passione che gli Sforza hanno ereditato dai Visconti. Tanto che si può parlare di una vera e propria scuola lombarda. Questa passione coinvolgeva direttamente anche il suo committente Ludovico il Moro.
Questo è il contesto nel quale di muove la brillante mente di Leonardo da Vinci. Arrivato a Milano e sapeva già giocare a scacchi ma senza dubbio apprese nuove pratiche alla corte degli Sforza. Nei Fogli di Windsor (ad esempio il nr. 12692r) datati tra il 1484 e il 1487 è presente proprio un rebus con una innegabile immagine della torre e la cui soluzione è “io arroccherò”. E ancora la mossa dell’arrocco ad un solo movimento non era stata inventata.
L’arrocco è una mossa che coinvolge il re e una delle due torri. È l’unica mossa che permette di muovere due pezzi contemporaneamente nonché l’unica in cui il re si muove di due caselle. Leonardo l’aveva già “inventato” prima del Cinquecento quando si usava farla ancora con due. Questa mossa viene fatta nell’apertura e serve spostare il re in una posizione più sicura e allo stesso tempo si porta una torre in una posizione più attiva d’attacco.
Bibliografia: Davide Shenk, Il gioco immortale. Storia degli Scacchi, Mondadori 2008 | https://www.milanosud.it/le-origini-degli-scacchi-in-lombardia-tra-principi-artisti-e-scienziati-del-rinascimento/
Immagine: Ritratto di Luca Pacioli, attribuito a Jacopo de’ Barbari (Museo Nazionale Capodimonte, Napoli)