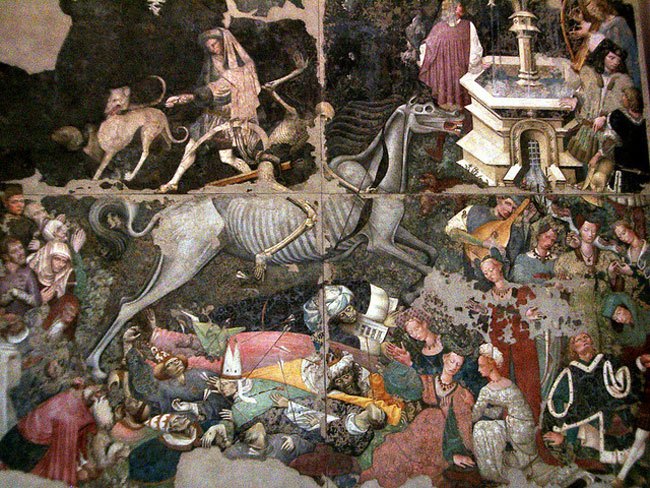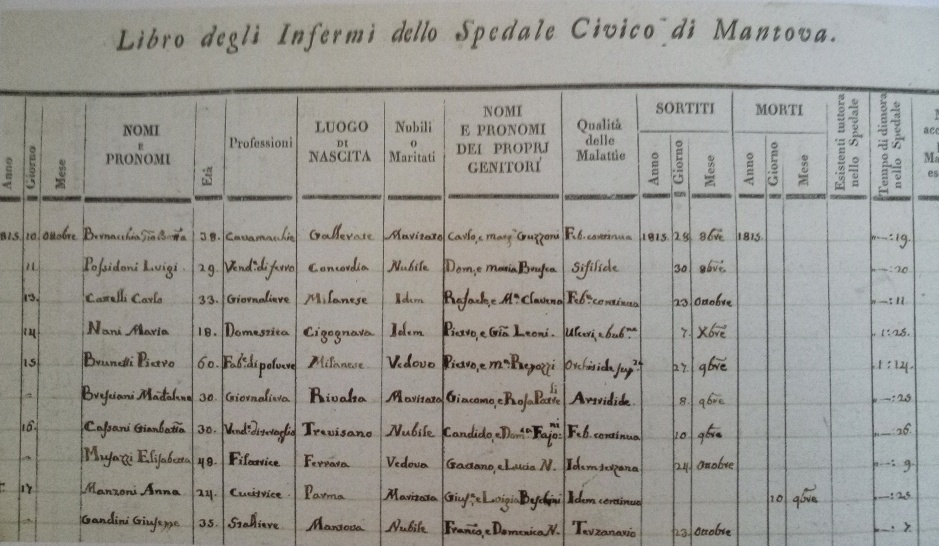Peccana, 23 luglio 1329. In tarda serata il corpo di Cangrande della Scala arriva in una località poco fuori Verona, vicino a Porta Vescovo. Ormai da un giorno la famiglia sapeva della morte perché avvertita da un emissario che a tutta velocità era partito da Treviso. Le disposizioni per le esequie erano molto precise: il principe sarebbe entrato in città il giorno 24 e accompagnato da un funerale triste ma grandioso, un grande corteo fino alla sepoltura (la prima) in Santa Maria Antica.
Presso la località Peccana c’era un ospedale in servizio alla chiesa di Sant’Apollinare. Qui viene preparato il corpo di Cangrande logorato da anni di battaglie e ferite e dal trasporto lungo oltre dieci ore nella calura di luglio. La salma infatti non arriva in buone condizioni: il ventre è già gonfio, gli arti superiori sono rigidi e si manifestano i primi segni della putrefazione. I medici della corte sono al lavoro per sistemare e aromatizzare il corpo.
Cangrande, dal busto alle cosce, è stato avvolto in una stretta e spessa fasciatura di bende di lino – almeno 5 strati – e imbevuta di unguenti. La fronte e la parte posteriore del capo sono protette da una garzatura più delicata. Le braccia furono lasciate libere, messe conserte con le mani a stringere i gomiti. La muscolatura era già rigida e non si poteva deporle lungo i fianchi come in genere avviene. In realtà non siamo certi che questa procedura sia avvenuta proprio a Verona o piuttosto già a Treviso proprio per permettere al corpo di viaggiare sicuro e protetto in buone condizioni. Nella bara Cangrande ci stava a fatica: le spalle sono strette verso l’alto quasi in modo innaturale, quasi ce lo avessero infilato con forza, di velocità, proprio nelle fasi concitate della preparazione per il trasporto.
Ciò che è certo è il lavoro dei sarti alla Peccana. Confezionano per il principe una veste di tessuto rosso su cui risaltava l’oro usato per gli ornati e in contrasto con la cromia delle altre sete. La parte anteriore del corpo, compreso il volto, era avvolta da un lungo lenzuolo giallo e oro scuro, a righe d’argento. Così doveva apparire la sua tomba tutta coverta a seta; una simbologia parlante del potere: il giallo e blu del Comune e il rosso e argento degli Scaligeri. Gli indumenti a fare da arredo non erano finiti qui: tre teli quadrangolari (sparsi nella cassa), un copricapo di seta, dei calzali in panno rosso, un cuscino a righe d’argento riempito con lana e piume. Una strategia simbolica, del colore e della sfarzosità delle vesti.
Bibliografia: Cangrande della Scala. La morte e il corredo di un principe nel medioevo europeo, Marsilio 2004
Immagine: Statua di Cangrande della Scala, Museo di Castelvecchio