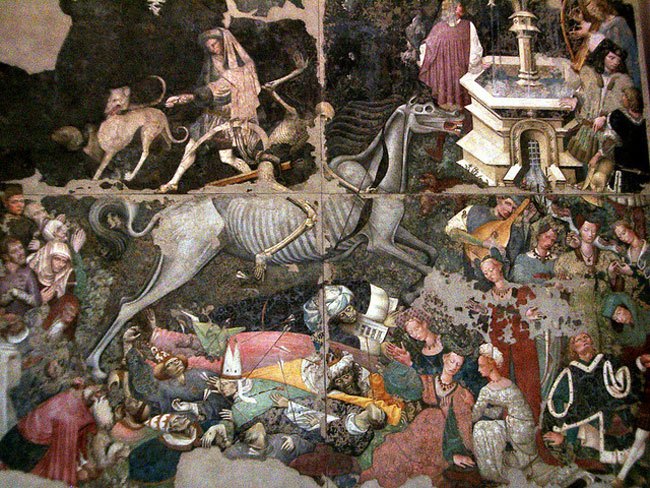Putney, Cinquecento. Walter Cromwell è il padre del futuro Primo ministro inglese Thomas. Di professione è fabbro ferraio e maestro birraio. Suo figlio avrebbe dovuto seguire le sue orme. La birra nella Londra del tempo era una bevanda diffusa nelle tantissime taverne. Per capirne la stretta relazione tra la birra e gli inglesi bisogna andare indietro fino al Duecento quando Londra era già nota per essere la città del bere smodato.
C’erano i vini e di qualità. Quelli del Reno e di Guascogna, di Borgogna e Madeira, il bianco spagnolo e il rosso portoghese. Ma i meno ricchi trangugiavano birra. Il luppolo si era iniziato a coltivare dal Trecento ma la birra in questo periodo viene importata. Se ne produce una bevanda curiosa chiamata stingo, birra e pepe. Nel Trecento esplode la mania della birra. Si contano 354 taverne e 1334 fabbriche di birra. Nel Quattrocento invece i birrai sono 269. I tempi erano maturi per la costituzione della Compagnia londinese dei Birrai, riconosciuta pubblicamente con tanto di stemma.
C’era bisogno anche di regole come quella del 1423 che imponeva ai rivenditori di vendere la birra nelle loro case solo in brocche di peltro sigillate. Chi non le avesse veniva multato. Ubriacarsi era diventato un problema al punto che nel 1574 furono chiuse duecento birrerie. In quest’epoca, ai tempi di Elisabetta I, erano presenti 26 fabbricanti di birra che producevano la Huffe Cup, Mad Dog, Angels’ Food, Lift Leg e Stride Weg. Dentro c’erano ginestrella, pepe, semi di edera, malto e avena. Ma la vera birra si produceva con il luppolo.
La sempre più dirompente popolarità della birra – e di conseguenza il suo consumo – trova l’attestazione nel 1643 quando per la prima volta viene imposta una tassa. Nel Seicento e nel Settecento la birra trova la sua consacrazione. Venne creata la moda della brown ale, la birra scura dolce, e poi la bitter – amarissima anche per Casanova – e la half and half. La più popolare divenne la pale ale, la birra chiara.
Bibliografia: Hilary Mantel, Wolf Hall, Fazi editore 2011 | Peter Ackroyd, Londra, una biografia, Neri Pozza 2013
Immagine: Monaco celleraio prova del vino, da ‘Li Livres dou Sant_’ manoscritto francese, tardo XIII secolo