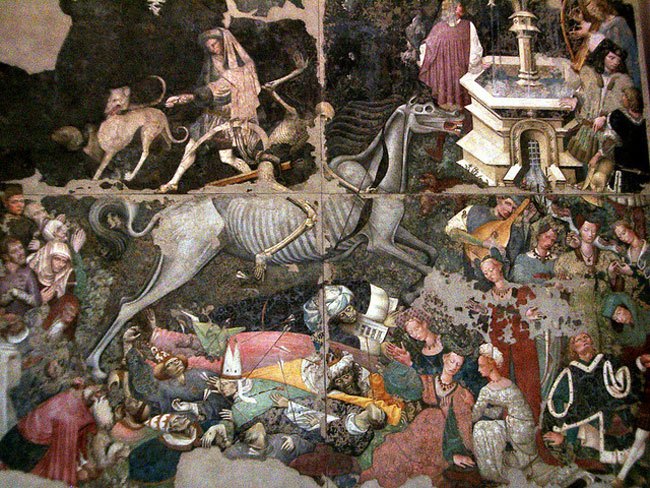La monetazione era affidata alla potestà del principe. Con i primi Capitani del Popolo venivano battuti i bolognini e gli aquilini. L’imperatore Enrico VI nel 1191 concesse a Bologna il privilegio di emettere un denaro che si chiamò bolognino. Successivamente venne chiamato piccolo quando iniziò la produzione di quello grosso che valeva come un soldo da 12 denari. Pesavi 1,41 grammi d’argento. Gli aquilini invece indicano, con nome generico, i denari e i grossi che portano l’aquila imperiale. Il periodo è quello svevo di Federico II. Verranno imitati in molte zecche dell’Italia settentrionale anche se inizialmente vengono prodotte solo a Merano dai conti del Tirolo.
A Mantova sarà Gianfrancesco che sostituì le precedenti monetazioni con il grosso d’argento in realtà non così differenti dalla tradizione medievale per aspetto, lega e peso. Era innovativo perché riportava sul recto lo stemma con le aquile inquartate – prima novità dal 1433 – e il nome del marchese – la seconda novità. Mentre sul verso la visione prospettica della città che racchiude al centro la raffigurazione della pisside.
Dopo l’apparato decorativo simbolico in Corte Vecchia con Pisanello, i Sacri Vasi fanno la loro presenza anche sulle monete. I Gonzaga si proclamano i protettori del Santo Graal e attivano il confronto – iconografico e tematico – con la leggendaria corte di Re Artù.
Bibliografia: Storia di Mantova. L’eredità gonzaghesca secoli XII – XVIII, a cura di Marzio A. Romani, Tre Lune Edizioni 2005
Immagine: Grosso da 4 denari. Genova, 1272